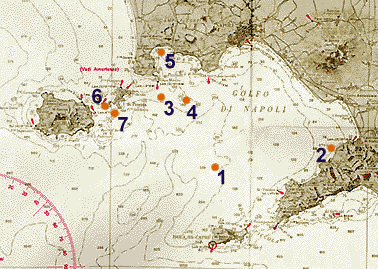| Il settore
sud-orientale è caratterizzato da substrato di natura
carbonatica che affiora con l'isola di Capri e tutta la
penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana. Quest'area
presenta pertanto una peculiare geomorfologia costiera
con numerosissime grotte emerse e sommerse disseminate
lungo pareti alte e scoscese di roccia calcarea molto
chiara, che si protendono in mare con forti pendenze fino
ad una profondità di oltre cinquanta metri dove comincia
un fondale piuttosto regolare e formato da un'ampia piana
fangosa lievemente degradante verso Ovest. Unico
affioramento roccioso considerevole presente in questo
settore è la "Secca di Vico Equense" meglio
nota come "Banco di Santa
Croce"(2).
Il settore nord-occidentale, che include i Campi Flegrei
e le due isole di Procida ed Ischia, presenta invece una
notevole attività vulcanica ed è costituito da
substrato solido di natura tufitica ed ignimbritica.
Conseguenza diretta della natura vulcanica dell'area
Flegrea è il paesaggio tormentato ed irregolare dei
fondali, che in questo settore, presentano numerosi
affioramenti, generalmente formati da resti di coni
vulcanici, come la secca di Miseno (3), di Penta Palumbo (4), la Fumosa (5),
le Formiche (6), la Catena (7);
sono inoltre presenti due profondi canyons che giungono
in vicinanza della costa presso l'isola di Procida (8) e presso Nisida (9).
Passiamo ora ad analizzare la distribuzione di alcune
delle comunità (Nota1) bentoniche
(Nota 2) più significative
presenti sui fondali del Golfo di Napoli fornendo alcune
indicazioni inerenti la biologia delle specie di maggior
interesse ecologico e paesaggistico che è possibile
incontrare nei vari popolamenti animali e vegetali. Tra i
vari parametri ambientali che condizionano la vita degli
organismi bentonici, l'illuminazione ed i movimenti delle
acque, insieme alla diversa natura del substrato,
costituiscono fattori di primaria importanza nel
determinare la distribuzione, la struttura e la dinamica
dei popolamenti biologici osservabili sui fondali marini.
In linea di massima, le variazioni che i vari fattori
ambientali presentano lungo l'asse verticale,
condizionano direttamente la distribuzione delle
comunità bentoniche che appaiono, pertanto, distribuite
in fasce parallele alla superficie del mare. E' però
assai frequente osservare come questa distribuzione sia
tutt'altro che rigorosa, in quanto i fattori ambientali
presentano molto spesso variazioni sostanziali anche
sull'asse orizzontale, osservandosi in questi casi una
distribuzione a macchie delle comunità (enclavi Nota 3). La vita degli
organismi vegetali nel mare è limitata solo alla fascia
più superficiale, la cosiddetta "zona fitale o
fotica", quì l'intensità della luce consente di
effettuare la fotosintesi clorofilliana, quel
meraviglioso processo foto-chimico, indispensabile alla
vita non solo negli oceani ma anche sulle terre emerse.
L'estensione di questa fascia varia secondo il grado di
torbidità dell'acqua e nel Golfo di Napoli mediamente
supera raramente i 30-35 metri, ed è quindi
prevalentemente in questa zona che si sviluppa
maggiormente la vita nel mare e dove le piante possono
giocare un ruolo determinante nella struttura e
nell'economia dell'intera comunità bentonica. Infatti è
possibile osservare come, laddove la profondità, le
caratteristiche geomorfologiche ed il tenore
d'illuminazione del fondo lo consentono, si sviluppano
popolamenti di tipo "fotofilo" (Nota 4) che presentano una forte
dominanza di organismi sessili di tipo vegetale, mentre a
maggiore profondità, sotto le sporgenze, nelle fenditure
della roccia, sulle pareti esposte a nord e nelle grotte,
su tutti i substrati dove in pratica arriva meno luce, i
popolamenti fotofili vengono gradualmente sostituiti da
popolamenti "sciafili" (Nota
5) caratterizzati dalla dominanza di organismi
bentonici (Nota 2) di tipo
animale, che meglio si adattano a vivere in condizioni di
luce attenuata o assai scarsa. Vi sono molte alghe che si
sono adattate a vivere in ambiente sciafilo in quanto
presentano particolari adattamenti fisiologici che
permettono loro di svilupparsi anche in condizioni di
luce attenuata. Tipiche alghe sciafile sono alcune
Rodoficee (Nota 6), che meglio si
adattano a vivere in assenza di luce diretta quando sono
più vicine alla superficie e che risultano dominanti
sulle altre alghe soprattutto in profondità. Le
peculiari caratteristiche geomorfologiche del settore
nord-occidentale del Golfo di Napoli, che presenta
pendenze mediamente assai lievi del fondo, favoriscono lo
sviluppo di popolamenti "fotofili" assai
estesi, costituiti sia da numerose specie di Alghe, in
prevalenza Cloroficee (Nota 7) e
Feoficee (Nota 8), che da estese
praterie di Fanerogame marine (Nota 9).
Nel settore sud-orientale, invece, l'elevata inclinazione
della costa, riduce considerevolmente la quantità di
luce che arriva su questi fondali; ciò ha come diretta
conseguenza la notevole riduzione dei popolamenti
"fotofili", la cui estensione raramente supera
i primi 10 metri di profondità, mentre risulta favorito
l'impianto di cospicui popolamenti di tipo
"sciafilo" che, talvolta, risalgono anche a
pochissimi metri. Dal punto di vista del paesaggio
sommerso, una delle comunità più belle e complesse del
bentos mediterraneo è, senza dubbio, la biocenosi
conosciuta come "coralligeno" (Nota 10), che nel Golfo di Napoli è
molto ben rappresentata in tutta la costa sorrentino-amalfitana, sulle numerose secche sparse nella
baia e su alcune pareti con forte pendenza presenti sulle
isole partenopee. Quella del coralligeno è una comunità
strutturalmente assai complessa costituita da una grande
diversità di specie che, grazie alle particolari
condizioni ambientali, riescono a coesistere in uno
spazio molto limitato. Questa comunità, tipica delle
falesie sommerse del Mare nustrum, riveste grande
interesse dal punto di vista biologico e naturalistico ed
è caratterizzata da condizioni ambientali mediamente
stabili con correnti regolari e continue, acque
costantemente fredde e luce assai scarsa con prevalenza
delle tonalità del blu. E' senza dubbio il rosso, con
molteplici ed intense tonalità, il colore dominante che
caratterizza le associazioni biologiche che si rinvengono
in questi fondali, anche se, la luce di un faro è
sufficiente per oservare tantissimi organismi dai colori
più disparati che si contendono tutto lo spazio
disponibile in una lenta ed incessante lotta. Un discorso
a parte va fatto per le numerose (oltre 50) grotte
sommerse presenti lungo le falesie sommerse della
costiera sorrentino-amalfitana. L'estrema riduzione o la
totale assenza della luce, unitamente alla riduzione dell'idrodinamismo e della temperatura, crea condizioni
ambientali assai limitanti che rendono praticamente
impossibile la vita della maggior parte delle alghe e
consentono, invece, la formazione di "enclavi"
superficiali che facilitano la risalita di organismi
tipici della fauna profonda. Ogni grotta presenta
caratteristiche geo-morfologiche diverse che condizionano
la circolazione dell'acqua al suo interno e che, di
riflesso, ne determinano la composizione e la
distribuzione degli organismi. In linea generale,
soprattutto nelle parti più interne e meno accessibili,
vi è spesso una consistente diminuzione del movimento
dell'acqua rispetto all'esterno e questo ridotto
idrodinamismo limita la presenza degli organismi, in
particolare i filtratori, favorendo l'insediamento di
specie specializzate (nota 11) che
meglio si adattano ad utilizzare come fonte di nutrimento
l'abbondante detrito organico disponibile in questi
ambienti. Le grotte si trovano a profondità molto
variabili, ma ciò che richiama immediatamente
l'attenzione dell'osservatore a mano a mano che ci si
avvicina all'entrata è il cambiamento alquanto repentino
del paesaggio sommerso in conseguenza delle variazioni
sia qualitative che quantitative degli organismi dei
popolamenti delle biocenosi circostanti. Quando una
grotta si trova a pochissima profondità è possibile
osservare, limitatamente all'entrata, alcune alghe,
soprattutto feoficee e rodoficee tipiche di ambienti sciafili, che ben si adattano ad un tenore di luce più
ridotto. Le uniche alghe che riescono a sopravvivere in
prossimità delle entrate delle grotte che si trovano a
maggiori profondità sono alcune rodoficee calcaree,
tipiche peraltro di ambienti sciafili come il coralligeno; ciò conferisce ai popolamenti delle grotte
una apparente analogia paesagistica con questa comunità,
anche se lo strato inferiore di concrezione è,
generalmente, molto meno sviluppato e poco adatto
all'insediamento di una endofauna consistente, mentre
spesso mancano quei grandi invertebrati filtratori di
aspetto arborescente che costituiscono lo strato eretto
del coralligeno. Nelle grotte, invece è lo strato
intermedio che si presenta ben sviluppato e dove vivono
la maggior parte degli organismi bentonici che
caratterizzano questa comunità. |